Evidence-based: evidenza (con riserva)
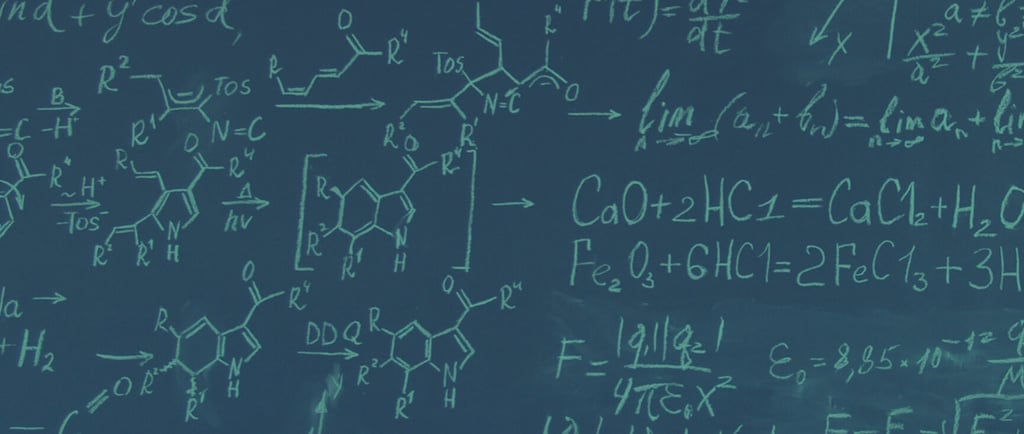
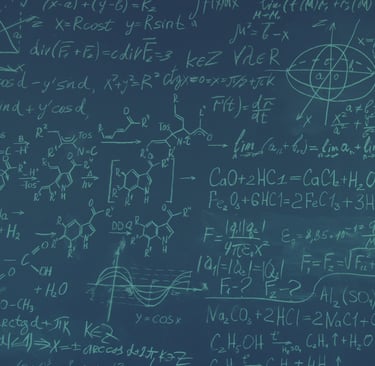
L’espressione evidence-based è ormai talmente abusata, persino nel linguaggio comune, da venire spesso utilizzata come sinonimo di affidabilità. Qualcosa che dunque non può modificarsi nel tempo. Nel contesto scientifico, però, la realtà è ben diversa: chi lavora con i numeri sa bene che nella scienza nulla è definitivo o immutabile.
Che cosa significa, allora, dire che qualcosa è evidence-based?
L’espressione ‘evidence-based’, letteralmente ‘basato sull’evidenza’, indica un’informazione ottenuta tramite strategie di ricerca. Possono rientrarvi dati epidemiologici provenienti da studi osservazionali, risultati di trial clinici in doppio cieco, modelli statistici o addirittura simulazioni computazionali. Tutte queste forme di evidenza contribuiscono sì all’avanzamento della conoscenza, ma non hanno lo stesso peso né comportano lo stesso grado di incertezza. Ogni tipologia porta con sé limiti specifici, assunzioni implicite e margini di errore differenti. Parlare di evidence-based senza esplicitare come questa evidenza è stata ottenuta significa spesso confondere, più che chiarire, il reale stato delle conoscenze.
La grande maggioranza degli studi da cui deriva questa espressione, siano essi osservazionali, sperimentali o descrittivi, afferiscono alla categoria degli studi epidemiologici. Questi analizzano la distribuzione di eventi in una popolazione più o meno ampia, nel tempo, permettendo di individuare andamenti, associazioni e differenze tra gruppi. Forniscono indicazioni preziose su ciò che accade e con quale frequenza. La loro forza sta nei grandi numeri e nella capacità di intercettare fenomeni reali, ma proprio per questo restano esposti a numerosi fattori di confondimento (bias). Possono suggerire correlazioni robuste certo, ma pochi consentono di stabilire relazioni causali dirette con un buon margine di confidenza.
Negli studi osservazionali, che possono essere ad esempio di coorte, di caso-controllo o trasversali, gli studiosi raccolgono informazioni su eventi senza che vi sia alcun controllo da parte del ricercatore, che quindi non interviene ma si limita ad osservare. Questi studi permettono di esplorare relazioni tra variabili in contesti reali, la loro evidenza è molto utile ma intrinsecamente limitata: l’assenza di controllo sperimentale rende difficile distinguere ciò che è direttamente correlato ad un evento, come ad esempio l’insorgere di una malattia, da ciò che è influenzato da fattori esterni non misurati. Lo scopo primario di questa tipologia di studi è di mostrare associazione e non nessi causali. I soggetti esposti a un fattore di rischio ‘x’ possono differire da quelli non esposti in altri modi, che influenzano in modo indipendente il loro rischio di malattia. Se tali fattori confondenti vengono identificati in anticipo, è possibile tenerne conto sia in fase di progettazione che nell'analisi dello studio. Esiste tuttavia la possibilità che fattori confondenti non vengano riconosciuti.
Per questa ragione, l’evidenza prodotta dagli studi osservazionali è preziosa ma limitata: consente di individuare associazioni anche robuste, ma difficilmente permette di stabilire relazioni causali dirette con un buon grado di confidenza.
Gli studi sperimentali, al contrario, sono generalmente meno esposti a bias, poiché è il ricercatore a determinare chi viene esposto ad un determinato fattore di rischio e chi no. Quando l’assegnazione avviene in modo casuale e il numero di soggetti coinvolti è sufficientemente ampio, anche i fattori confondenti non riconosciuti tendono a distribuirsi in modo equilibrato tra i gruppi, riducendo la probabilità che influenzino sistematicamente i risultati.
Questo maggiore controllo ha però dei limiti che non sono solo metodologici, ma anche etici. Nella ricerca sugli esseri umani non si può certo esporre deliberatamente i soggetti a rischi potenzialmente gravi, e ciò limita l'applicazione dei metodi sperimentali nell'indagine sull'eziologia delle malattie. Per questa ragione, tali studi trovano spazio soprattutto nella valutazione di strategie preventive o terapeutiche.
In questo contesto si collocano gli studi clinici randomizzati controllati, spesso considerati il riferimento più solido per valutare l’efficacia di un intervento, come nel caso dei farmaci. La randomizzazione, il controllo delle variabili e, quando possibile, il doppio cieco riducono molte fonti di bias e permettono l’identificazione di meccanismi causa-effetto più affidabili rispetto agli studi osservazionali. Anche questa forma di evidenza, tuttavia, non è assoluta. I risultati dipendono dal disegno dello studio, dalle caratteristiche e dalla numerosità della popolazione selezionata, dalla durata dell’osservazione e dalle condizioni sperimentali adottate, che per loro natura tendono a semplificare sistemi biologici che in realtà sono per natura molto complessi.
È proprio nel passaggio dal bancone di laboratorio alla comunicazione che il termine evidence-based rivela tutta la sua ambiguità. Nel tentativo di rendere risultati complessi più accessibili, la sintesi tende talvolta a trasformarsi in semplificazione estrema e, in alcuni casi, in un’illusione di certezza. L’espressione “basato sull’evidenza” finisce così per suggerire un grado di affidabilità che la conoscenza scientifica, per sua natura, non solo non possiede ma rifiuta.
La sintesi è uno strumento necessario della comunicazione scientifica, ma diventa problematica quando il risultato viene semplificato all’estremo presentandolo come conclusivo e definitivo. In questi casi, l’evidenza smette di essere una descrizione parziale di ciò che sappiamo in un determinato momento e viene implicitamente interpretata come una verità acquisita, non più soggetta a revisione.
Quando emergono nuovi dati che modificano o stravolgono completamente le interpretazioni precedenti, ciò ha un notevole impatto sulla percezione pubblica della scienza. Quello che per la comunità scientifica rappresenta un progresso naturale del sapere può apparire al grande pubblico come una smentita o una contraddizione. La revisione delle conoscenze viene così letta non come una conferma della solidità del metodo scientifico, ma come un segno di incertezza o di incoerenza.
La fiducia viene meno non perché la scienza “cambia idea”, ma perché era stata comunicata come se non potesse farlo. La promessa implicita di certezze, anche quando nasce da una sintesi ben intenzionata, espone la comunicazione scientifica al rischio di generare disillusione proprio nel momento in cui il sapere evolve.
Parlare di evidence-based in modo rigoroso significa quindi assumersi una responsabilità ulteriore: chiarire quale evidenza è disponibile, in quali condizioni è stata prodotta e quali limiti ne circoscrivono l’interpretazione. Non per indebolire il messaggio scientifico, ma, al contrario e paradossalmente, per renderlo più solido.
La scienza non può avanzare se si elimina l’incertezza. Comunicarla senza semplificazioni estreme implica rinunciare a risposte definitive rassicuranti accettando che la conoscenza procede via via per aggiustamenti. Riconoscere questi limiti non indebolisce la scienza, né ne riduce l’affidabilità. Al contrario, è ciò che ne rende possibile il progresso. La conoscenza scientifica avanza proprio perché è disposta a rivedere sé stessa, a correggersi e a restare, per definizione, incompleta.
APPROFONDIMENTI:
