CRISPR/Cas9: scoperta, funzionamento e applicazioni del più avanzato sistema di genome editing
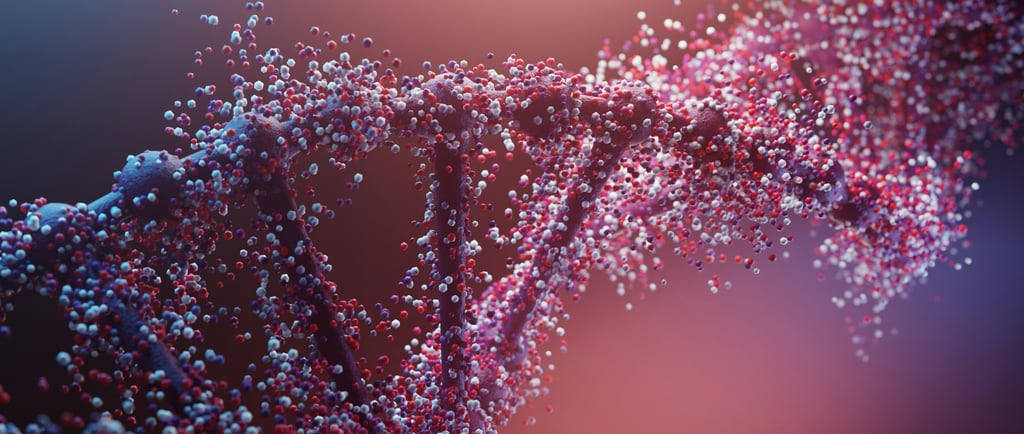
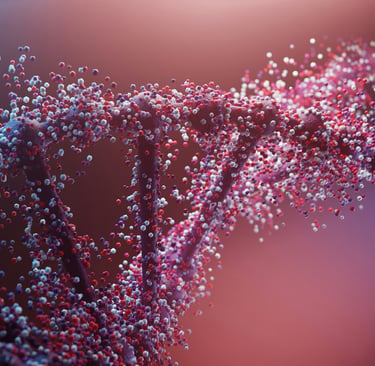
L’acronimo CRISPR/Cas9 sta per ‘Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats / CRISPR-associated protein 9’. Identificato inizialmente come sistema di difesa adattativa in numerosi procarioti, viene oggi sfruttato come strumento di ingegneria genetica ad alta precisione. Questa tecnologia consente la modificazione mirata del DNA delle cellule attraverso la rimozione, l’aggiunta o la sostituzione di specifiche sequenze nucleotidiche.
Sebbene metodologie di genome editing fossero già disponibili prima della diffusione di CRISPR/Cas9 (ad esempio nucleasi a dita di zinco e TALENs), tali strumenti risultano meno efficienti, più complessi da progettare e caratterizzati da un livello di precisione inferiore. L’introduzione di CRISPR/Cas9 ha quindi rappresentato un progresso sostanziale, aprendo prospettive applicative che, fino a pochi decenni fa, appartenevano più alla narrativa di fantascienza che alla pratica sperimentale.
1. Origini del sistema CRISPR
Il sistema CRISPR fu identificato per la prima volta nel 1987 all’interno del genoma di Escherichia coli, in cui si osservò la presenza di sequenze ripetute con regolarità intervallate da spacer , cioè tratti di DNA non ripetitivo. Studi successivi hanno dimostrato che tali sequenze spaziatrici derivano da frammenti di genomi virali incontrati in precedenza dal batterio o da suoi progenitori. Esse costituiscono una sorta di “memoria molecolare” che permette il riconoscimento di futuri agenti infettivi. Queste sequenze vengono infatti attivamente trascritte dal batterio, andando a costituire quello che è chiamato gRNA o RNA guida.
La proteina Cas9, invece, è un’endonucleasi che , facendosi guidare gRNA, ha il compito di introdurre rotture a doppio filamento nel DNA bersaglio, purché quest’ultimo presenti una sequenza complementare all’ RNA guida. In presenza di un’infezione ricorrente, il gRNA si appaia al DNA del virus e indirizza Cas9 sul punto preciso da clivare, determinando la degradazione del genoma virale e l’inattivazione dell’agente patogeno.
La comprensione di questo meccanismo ha portato Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna a concepire, nei primi anni 2010, la possibilità di adattare CRISPR/Cas9 come strumento universale per il genome editing in cellule eucariotiche. L’impatto rivoluzionario della loro scoperta è stato riconosciuto nel 2020 con l’assegnazione del Premio Nobel per la Chimica, sottolineando l’enorme rilevanza scientifica e applicativa di questa tecnologia.
2. Meccanismo d’azione del sistema CRISPR/Cas9
L’attività di CRISPR/Cas9 si fonda sul riconoscimento specifico del DNA bersaglio da parte di un RNA guida (gRNA o sgRNA), progettato per presentare complementarietà di basi con una determinata sequenza genica, denominata protospacer. Perché Cas9 possa legarsi e tagliare il DNA, è indispensabile la presenza di un breve motivo nucleotidico adiacente al protospacer, detto PAM (Protospacer Adjacent Motif). Nel caso di Streptococcus pyogenes Cas9, il PAM canonico è rappresentato dalla sequenza 5’-NGG-3’. Cas9 induce una rottura a doppio filamento (double-strand break, DSB) avviene tipicamente tre nucleotidi a monte del PAM.
Una volta introdotta la DSB, la cellula attiva i propri sistemi endogeni di riparazione del DNA che determineranno l’esito finale dell’editing genico. Ci sono due principali vie:
- Non-Homologous End Joining (NHEJ)
La giunzione delle estremità non omologhe è un meccanismo prevalente nelle cellule eucariotiche, caratterizzato da rapidità ma scarsa fedeltà. In assenza di un filamento stampo, le estremità del DNA vengono semplicemente riallineate e ricongiunte, spesso con l’inserzione o la delezione (indel) di poche basi nucleotidiche. Questo tipo di errore può comportare uno slittamento della cornice di lettura (frameshift) con conseguente produzione di una proteina tronca o non funzionale. In biologia molecolare, l’NHEJ è sfruttato intenzionalmente per silenziare geni o generare knock-out genici.
- Homology-Directed Repair (HDR)
Se alla cellula viene fornito un donor template – una sequenza di DNA omologo contenente la correzione desiderata o l’inserimento di nuove sequenze – la DSB può essere riparata tramite ricombinazione omologa. Questo meccanismo consente modifiche mirate come la correzione di mutazioni puntiformi, l’inserimento di geni reporter o la sostituzione di alleli patologici con versioni funzionali. Tuttavia, l’HDR è meno efficiente dell’NHEJ ed è maggiormente attivo in fasi specifiche del ciclo cellulare (principalmente in fase S e G2, quando la cromatina è più accessibile e i meccanismi di ricombinazione sono fisiologicamente attivi).
Le tecniche di genome editing precedenti, come nucleasi a dita di zinco (ZFN) e TALENs, richiedevano la progettazione e la sintesi di proteine specifiche per ciascun target, con procedure laboriose, costose e meno flessibili. Al contrario, il sistema CRISPR/Cas9 si basa sull’uso di un RNA guida, la cui sintesi è semplice, rapida ed economica. Inoltre, la natura compatta del complesso gRNA-Cas9 facilita la consegna intracellulare mediante plasmidi, vettori virali o sistemi di delivery non virali, rendendolo un metodo più versatile e scalabile rispetto ai precedenti.
3. Varianti e ottimizzazioni del sistema CRISPR
Il sistema CRISPR/Cas9 derivato da Streptococcus pyogenes (SpCas9) rappresenta la versione più utilizzata per il genome editing. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni sono state sviluppate numerose varianti e adattamenti, con l’obiettivo di migliorare la specificità, ridurre gli effetti off-target (modifiche non intenzionali in altre parti del genoma), ampliare la gamma di applicazioni e consentire interventi più fini sulla sequenza genomica.
3.1. Varianti della proteina Cas9
Oltre alla forma wild-type, esistono oggi diverse versioni ingegnerizzate di Cas9:
Cas9 nickase (nCas9): ottenuta mediante mutazione di uno dei due domini nucleasici, è in grado di introdurre un taglio a singolo filamento (nick). Se due nCas9 vengono dirette in posizioni opposte e ravvicinate, si ottiene un DSB con maggiore specificità poiché sarà statisticamente più difficile che due enzimi sbaglino commettendo lo stesso errore.
dead Cas9 (dCas9): mutazioni inattivanti in entrambi i domini catalitici rendono la proteina incapace di tagliare il DNA. Tuttavia, dCas9 mantiene la capacità di legare sequenze target grazie al gRNA, permettendo così applicazioni come la CRISPR interference (CRISPRi), in cui l’espressione genica viene repressa, o la CRISPR activation (CRISPRa), in cui dCas9 è fuso ad attivatori trascrizionali.
High-fidelity Cas9 (eSpCas9, SpCas9-HF1, HypaCas9 e altre): varianti con mutazioni mirate a ridurre l’interazione con sequenze parzialmente complementari, diminuendo gli effetti off-target senza compromettere l’efficienza.
Oltre a Cas9, esistono altre endonucleasi utilizzabili nel sistema CRISPR:
Cas12a (Cpf1): riconosce un PAM differente (tipicamente 5’-TTTV-3’), introduce tagli ‘staggered’ (con estremità coesive) e utilizza un gRNA più corto, ampliando le possibilità di target.
Cas13: a differenza di Cas9 e Cas12, agisce sull’RNA anziché sul DNA, rendendola uno strumento utile per il knockdown trascrizionale e per applicazioni diagnostiche basate su RNA.
Cas14: una nucleasi più piccola e versatile, utile per applicazioni che richiedono vettori di ridotte dimensioni.
3.2. Base editing
Il base editing rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al semplice taglio del DNA. In questo approccio, Cas9 è utilizzata in forma di nickase fusa a enzimi deaminasi. Ciò consente la conversione precisa di una base in un’altra (es. C→T o A→G) senza introdurre DSB. Esistono due tipi di deaminasi utilizzate: le deaminasi della citidina (CBE), che convertono la citosina (C) in uracile (U), e le deaminasi dell’adenosina (ABE), che convertono l’adenina (A) in inosina (I), la quale durante la replicazione viene successivamente letta come guanina (G).
Poiché il base editing può modificare solo un singolo nucleotide alla volta, questa tecnica viene comunemente utilizzata per creare o correggere polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) e mutazioni puntiformi, oppure per il knockout di geni.
3.3. Prime editing
Il prime editing è una tecnologia di più recente sviluppo (2019) che combina Cas9 nickase con una trascrittasi inversa e una RNA guida estesa (pegRNA). La nCas9 introduce un taglio a singolo filamento. La trascrittasi inversa a questo punto sintetizza un nuovo pezzo di DNA partendo dal pegRNA. Quest’ultimo è più lungo dei classici gRNA poiché contiene la sequenza di legame della trascrittasi inversa più la sequenza che si vuole inserire nel DNA target. Questo sistema consente non solo di correggere mutazioni puntiformi, ma anche di introdurre dunque inserzioni, delezioni o sostituzioni più complesse senza necessità di DSB. Nel caso di un sistema che ha come scopo l’inserzione di una sequenza, cosa accade nel filamento di DNA che non subisce il taglio? Subito dopo l’inserimento di una nuova sequenza di DNA nel target non ci sarà complementarietà tra i due filamenti di DNA. Tuttavia, durante la riparazione e la successiva replicazione, la cellula risolve il disallineamento poiché la sequenza introdotta verrà copiata anche sul filamento complementare ristabilendo così la complementarietà.
4. Applicazioni biomediche di CRISPR/Cas9
Il sistema CRISPR/Cas9 ha rivoluzionato le prospettive della biomedicina, introducendo la possibilità di manipolare in modo rapido, specifico ed economicamente più accessibile il genoma di cellule e organismi. Le applicazioni spaziano dalla generazione di modelli sperimentali fino allo sviluppo di terapie innovative per malattie genetiche, infettive e oncologiche.
CRISPR/Cas9 è particolarmente promettente nel trattamento delle malattie monogeniche, caratterizzate da mutazioni in un singolo gene. Attraverso NHEJ o HDR è possibile inattivare un gene patologico o correggere la mutazione responsabile. Alcuni esempi:
Anemia falciforme e beta-talassemia: trial clinici ex vivo hanno dimostrato l’efficacia del sistema nell’indurre la riattivazione dell’emoglobina fetale (HbF), compensando il difetto della catena β-globinica.
Amaurosi congenita di Leber (LCA10): primi studi in vivo hanno testato l’iniezione di complessi CRISPR/Cas9 per correggere mutazioni nel gene CEP290 direttamente nelle cellule retiniche.
Fibrosi cistica, distrofia muscolare di Duchenne e altre patologie rare: ricerche precliniche sono in corso per valutare la fattibilità della correzione genica.
4.1. Esempi clinici significativi
Casgevy: la prima terapia CRISPR approvata
Un traguardo storico è stato raggiunto nel 2023 con l’approvazione, da parte della Food and Drug Administration (FDA) e successivamente da agenzie regolatorie europee, della prima terapia basata su CRISPR/Cas9, denominata Casgevy (exagamglogene autotemcel, exa-cel).
Casgevy è stata sviluppata per il trattamento dell’anemia falciforme e della beta-talassemia trasfusione-dipendente, entrambe patologie ereditarie dovute a mutazioni nella β-globina (HBB). L’emoglobina, responsabile tra le altre cose del trasporto di ossigeno attraverso il sangue alle cellule, è una proteina costituita da 4 catene peptidiche più piccole, 2 β globine e 2 α globine. Le forme mature di β globina vengono prodotte dopo la nascita e vanno a sostituire delle catene fetali di globina (γ globina o HbF) che vengono prodotte solo nella vita fetale appunto. I geni della γ globina vengono silenziati dopo la nascita quando, in concomitanza, si iniziano a produrre catene β. I ricercatori hanno agito in modo da distruggere il meccanismo che reprime la produzione di emoglobina fetale. Questa strategia era considerata più semplice rispetto alla riparazione del gene della β globina non funzionante. Le mutazioni presenti in questo gene possono infatti essere molteplici. Con questo approccio si ottiene un mix di produzione di catene fetali, catene beta e ovviamente catene alfa. La quantità di catene fetali prodotte è tuttavia sufficiente a ripristinare globalmente la funzionalità emoglobinica nonostante siano presenti ancora catene beta difettose.
L’approccio utilizzato è di tipo ex vivo:
Si prelevano cellule staminali ematopoietiche dal paziente.
In laboratorio, CRISPR/Cas9 viene utilizzato per inattivare un repressore (il gene BCL11A) che normalmente sopprime l’espressione dell’HbF.
Una volta reinfuse, le cellule modificate producono nuovamente HbF in quantità sufficiente a compensare il difetto dell’emoglobina adulta.
Gli studi clinici hanno dimostrato che, dopo il trattamento, la maggior parte dei pazienti è risultata libera da crisi vaso-occlusive (nel caso dell’anemia falciforme) o indipendente dalle trasfusioni (nel caso della beta-talassemia). Questo rappresenta la prima dimostrazione concreta dell’efficacia terapeutica di CRISPR nell’uomo.
Terapia personalizzata per deficit di CPS1
Un ulteriore caso di rilievo è stato riportato nel 2025, riguardante lo sviluppo di una terapia personalizzata basata su CRISPR/Cas9 per un neonato affetto da un grave e raro disturbo metabolico: il deficit di carbamoil-fosfato sintetasi 1 (CPS1 deficiency).
Questa patologia compromette il ciclo dell’urea, impedendo l’eliminazione dell’ammoniaca dal sangue e determinando iperammoniemia letale già nei primi giorni di vita. Le opzioni terapeutiche standard comprendono una dieta ipoproteica, l’uso di farmaci scavenger dell’ammoniaca e, nei casi più gravi, il trapianto di fegato – tuttavia, molti pazienti non sopravvivono fino all’intervento.
In questo contesto, un team di ricercatori ha progettato una strategia CRISPR denominata k-ABE (K dal nome del paziente - per sottolineare che si tratta di un approccio sviluppato ad hoc per una singola persona - e ABE perché utilizza una Adenine Base Editor), sfruttando nanoparticelle lipidiche (LNPs) come vettore per trasportare verso il fegato una Cas9 contenente un adenine base editor e ovviamente un gRNA. Si tratta di una Cas9 che effettua un taglio su un solo filamento del DNA bersaglio per promuovere la conversione di una coppia di basi A-T in G-C al fine di ripristinare la sequenza corretta (il deficit deriva da una mutazione puntiforme che dà origine ad un codone di stop determinando la produzione di un enzima tronco, non funzionante).
Si tratta del primo esempio documentato di una terapia CRISPR personalizzata concepita e sviluppata “su misura” per un singolo paziente, a testimonianza delle potenzialità future della medicina di precisione basata su genome editing.
Lo sviluppo di questo approccio è passato attraverso test su linee cellulare di epatociti contenenti la mutazione del paziente per testare diversi ABE e gRNA. Una volta selezionata la combinazione più efficace si è passati ai test su topi e poi su primati non umani per calcolare anche la dose di trattamento da somministrare.
Con un’autorizzazione speciale dell’FDA si è poi passati alla somministrazione del trattamento sul bambino. Dopo 3 somministrazioni, il piccolo ha mostrato una migliorata tolleranza alle proteine alimentari e una ridotta necessità dell’uso di farmaci scavengers per l’ammoniaca.
Per l’elaborazione della terapia gli scienziati hanno impiegato solo 6 mesi. Anche se è ancora presto per parlare di vera e propria cura, il sistema CRISPR/Cas9 ha iniziato a trasformare radicalmente l’approccio alla cura delle malattie genetiche.
5. Applicazioni in biotecnologia e ricerca di base
Oltre all’ambito clinico, CRISPR/Cas9 sta rapidamente stravolgendo lo studio della biologia e le biotecnologie:
Nello sviluppo di modelli sperimentali: la generazione di organismi knock-out o knock-in (topi, zebrafish, Drosophila) è diventata molto più rapida e accessibile rispetto a tecniche precedenti.
Negli screening funzionali: librerie genome-wide di gRNA consentono di silenziare sistematicamente ogni gene di un genoma, permettendo l’identificazione di geni essenziali, pathways coinvolti in malattie o meccanismi di resistenza farmacologica.
In agricoltura: CRISPR è impiegato per sviluppare varietà vegetali resistenti a patogeni (aiutando a ridurre sensibilmente l’utilizzo di pesticidi) o con caratteristiche nutrizionali migliorate.
Nella microbiologia industriale: la modifica di microrganismi produttori di antibiotici, enzimi o metaboliti permette di ottimizzare la resa dei processi industriali.
6. Limiti e problematiche
Nonostante l’enorme potenziale, l’utilizzo del sistema CRISPR/Cas9 non è privo di limitazioni e criticità. Uno dei principali problemi riguarda la specificità del taglio: Cas9, infatti, non è sempre perfettamente fedele e può riconoscere e tagliare sequenze simili ma non identiche al target, generando mutazioni indesiderate note come effetti off-target. Questo fenomeno rappresenta una sfida importante, soprattutto in ambito clinico, dove anche minime modificazioni non volute, in altre regioni del genoma, potrebbero avere conseguenze patologiche. Per affrontare questa limitazione, sono state sviluppate varianti ad alta fedeltà (come SpCas9-HF1, eSpCas9 o HypaCas9) e sono stati messi a punto algoritmi bioinformatici in grado di predire con maggiore accuratezza i potenziali siti di legame indesiderati.
Un secondo limite cruciale riguarda l’efficienza della riparazione tramite HDR. Sebbene questa via rappresenti la strategia ideale per introdurre modifiche precise, la cellula privilegia in modo naturale la riparazione tramite NHEJ, più semplice ma meno accurata. Inoltre, l’HDR è attivo soprattutto durante le fasi S e G2 del ciclo cellulare, restringendo le potenzialità del sistema per la correzione puntuale di mutazioni in tessuti come quello nervoso o cardiaco, dove le cellule sono per lo più post-mitotiche.
Un ulteriore ostacolo riguarda le modalità con cui si veicola il sistema in vivo. Introdurre il complesso CRISPR/Cas9 nelle cellule bersaglio in modo efficiente e sicuro rimane una delle principali sfide della terapia genica. I vettori virali, come gli adeno-associati (AAV) o i lentivirus, garantiscono un’elevata efficienza ma presentano rischi di immunogenicità, integrazione indesiderata nel genoma o limitazioni di capacità di carico. D’altro canto, sistemi alternativi come le nanoparticelle lipidiche offrono un profilo di sicurezza migliore, ma talvolta a scapito dell’efficacia.
Anche la risposta immunitaria costituisce una problematica da non trascurare. Poiché Cas9 deriva da batteri patogeni comuni come Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus, molti individui possiedono anticorpi pre-esistenti o cellule T in grado di riconoscere questa proteina come estranea. Ciò potrebbe ridurre l’efficacia del trattamento o, nei casi peggiori, scatenare reazioni avverse.
Infine, le potenzialità di CRISPR sollevano inevitabilmente questioni di natura etica e regolatoria. L’uso dell’editing genomico su cellule germinali ed embrioni umani è oggetto di un acceso dibattito internazionale: se da un lato apre alla possibilità di prevenire gravi malattie ereditarie, dall’altro pone interrogativi sui limiti etici che ci si dovrebbero porre. È necessario quindi bilanciare il progresso biotecnologico con principi di responsabilità etica e trasparenza tramite apposite leggi.
7. Prospettive future
Le prospettive future del sistema CRISPR/Cas9 sono estremamente promettenti e si articolano su più fronti. Sul piano tecnico, l’attenzione è rivolta al miglioramento della precisione e della versatilità. Tecnologie derivate come il base editing e il prime editing stanno già dimostrando di poter introdurre modificazioni mirate senza generare rotture a doppio filamento, riducendo così drasticamente gli effetti collaterali e ampliando la gamma di mutazioni correggibili. Parallelamente, la continua scoperta di nuove nucleasi CRISPR in diversi microrganismi arricchisce il repertorio degli strumenti disponibili, fornendo proteine più piccole, più specifiche e meglio adattabili a differenti contesti cellulari.
Sul versante applicativo, le terapie personalizzate rappresentano una delle aree di sviluppo più entusiasmanti. L’esempio del trattamento basato su base editing per un neonato affetto da deficit di CPS1 ha dimostrato che CRISPR può essere adattato a esigenze cliniche individuali, inaugurando l’era della medicina di precisione ad personam. In prospettiva, si potrebbe immaginare un futuro in cui i pazienti con malattie rare abbiano accesso a terapie disegnate appositamente per correggere la loro mutazione specifica, senza la necessità di lunghi e complessi programmi di drug discovery tradizionale.
Un’altra frontiera in espansione riguarda la diagnostica molecolare. Alcune varianti, come Cas12 e Cas13, possiedono attività collaterali che possono essere sfruttate come biosensori ultrasensibili per il rilevamento di acidi nucleici. Durante la pandemia di COVID-19, queste tecnologie sono state testate come strumenti diagnostici rapidi ed economici, aprendo la strada a possibili applicazioni anche per altre malattie infettive o per il monitoraggio ambientale.
Non va infine trascurato il ruolo delle considerazioni etiche e regolatorie. La velocità con cui la tecnologia CRISPR si sta sviluppando impone la definizione di linee guida chiare e condivise a livello internazionale, in grado di garantire un uso sicuro e responsabile. La sfida consisterà nel favorire l’innovazione, evitando però derive non controllate che potrebbero minare la fiducia pubblica o generare disuguaglianze nell’accesso alle cure.
In conclusione, sebbene il sistema CRISPR/Cas9 non sia privo di limiti, il suo potenziale trasformativo è tale da renderlo uno degli strumenti più potenti mai introdotti nella biologia moderna. Nei prossimi anni sarà verosimilmente al centro non solo della ricerca biomedica e biotecnologica, ma anche del dibattito culturale ed etico che accompagnerà la rivoluzione dell’editing genomico.
BIBLIOGRAFIA E APPROFONDIMENTI:
- CRISPR Genome Surgery in Stem Cells and Disease Tissues, (book), Edited by: Stephen H. Tsang, DOI: 10.1016/C2018-0-02310-5
- Laurent M, Geoffroy M, Pavani G, Guiraud S. CRISPR-Based Gene Therapies: From Preclinical to Clinical Treatments. Cells. 2024 May 8;13(10):800. doi: 10.3390/cells13100800. PMID: 38786024; PMCID: PMC11119143.
- Frangoul H, Altshuler D, Cappellini MD, Chen YS, Domm J, Eustace BK, Foell J, de la Fuente J, Grupp S, Handgretinger R, Ho TW, Kattamis A, Kernytsky A, Lekstrom-Himes J, Li AM, Locatelli F, Mapara MY, de Montalembert M, Rondelli D, Sharma A, Sheth S, Soni S, Steinberg MH, Wall D, Yen A, Corbacioglu S. CRISPR-Cas9 Gene Editing for Sickle Cell Disease and β-Thalassemia. N Engl J Med. 2021 Jan 21;384(3):252-260. doi: 10.1056/NEJMoa2031054. Epub 2020 Dec 5. PMID: 33283989.
- Musunuru K, Grandinette SA, Wang X, Hudson TR, Briseno K, Berry AM, Hacker JL, Hsu A, Silverstein RA, Hille LT, Ogul AN, Robinson-Garvin NA, Small JC, McCague S, Burke SM, Wright CM, Bick S, Indurthi V, Sharma S, Jepperson M, Vakulskas CA, Collingwood M, Keogh K, Jacobi A, Sturgeon M, Brommel C, Schmaljohn E, Kurgan G, Osborne T, Zhang H, Kinney K, Rettig G, Barbosa CJ, Semple SC, Tam YK, Lutz C, George LA, Kleinstiver BP, Liu DR, Ng K, Kassim SH, Giannikopoulos P, Alameh MG, Urnov FD, Ahrens-Nicklas RC. Patient-Specific In Vivo Gene Editing to Treat a Rare Genetic Disease. N Engl J Med. 2025 Jun 12;392(22):2235-2243. doi: 10.1056/NEJMoa2504747. Epub 2025 May 15. PMID: 40373211.
COVER IMAGE CREDIT: Foto di MJH SHIKDER su Unsplash
